|
Ascolta il post in Audio
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Introduzione
Il Padre nostro (in latino Pater Noster, in greco Πάτερ ἡμῶν), così chiamato dalle parole iniziali, detto anche Preghiera del Signore, è la più conosciuta delle preghiere Cristiane.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo Nome,
venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua Volontà come in Cielo così in Terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Tuo è il Regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli.
Amen
(Padre nostro)
PATER Noster qui es in cælis: sanctificétur Nomen Tuum;
advéniat Regnum Tuum; fiat Volúntas Tua,
sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hódie;
et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris;
et ne nos indúcas in tentatiónem;
sed líbera nos a malo.
Quia Tuum est Regnum, et potestas, et Gloria, in saecula.
Amen
(PATER noster – Latin)

Padre nostro in Greco antico
Secondo quanto riportato nel Vangelo secondo Luca (Lc 11, 1), la preghiera fu insegnata da Gesù ai suoi discepoli quando, mentre si era ritirato in preghiera, gli fu chiesto che insegnasse loro a pregare, così come Giovanni il Battista aveva insegnato ai suoi discepoli.
Il Padre Nostro nella Bibbia
Nei due racconti Evangelici (Vangeli secondo Matteo e Luca) è Gesù che insegna il Padre Nostro ai suoi discepoli in questa magnifica invocazione a DIO. Si deve ricordare che la religiosità Ebraica del tempo era molto rigida e aveva riti e orazioni molto precisi. La relazione con DIO era qualcosa di molto delicato, e per questo i discepoli chiesero al Messia di indicar loro il modo corretto con il quale rivolgersi al SIGNORE DIO, evidenziando così la completa fiducia che riponevano nel suo insegnamento.
Con la preghiera che insegnò loro, Gesù cercò di rompere con l’attitudine che tendeva ad allontanare l’uomo da DIO, e trovò nella semplicità lo strumento che facilitasse il dialogo con quell’Assoluto che Gesù chiamò ed insegnò a chiamare “Padre”.
Discordie tra le traduzioni: “Non ci indurre” e “Non abbandonarci”.
Nel mondo odierno il credente, o chiunque abbia desiderio di accrescere la propria conoscenza, si scontra spesso con la marea di occasioni che possono facilmente distrarre l’uomo o la donna, o addirittura far perdere la direzione da seguire.
La tentazione è sicuramente una prova difficile, e sicuramente DIO, il CREATORE, non induce i Suoi figli in quanto è riportato nel Nuovo Testamento:
12 Beato l’uomo che sopporta la tentazione, perché una volta superata la prova riceverà la corona della vita che il SIGNORE ha promesso a quelli che lo amano.
13 Nessuno, quando è tentato, dica: “Sono tentato da DIO”; perché DIO non può essere tentato dal male e non tenta nessuno al male.
14 Ciascuno piuttosto è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce;
15 poi la concupiscenza concepisce e genera il peccato, e il peccato, quand’è consumato, produce la morte.
(Giacomo 1, 12-14)
Ed anche nella Lettera ai Corinzi San Paolo attesta che la tentazione non viene da DIO, è sì permessa, ma altrettanto è elargita dal SIGNORE la forza per superarla:
“DIO infatti è degno di fede e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze ma, insieme con la tentazione, vi darà anche il modo di uscirne per poterla sostenere.”
(1 Cor 10, 13)
Le traduzioni nelle varie lingue moderne spesso non rendono il senso del significato originale di questa richiesta; in particolare la parola italiana “indurre” è un calco fedele del latino inducas, a sua volta traduzione del greco.
La Bibbia di Gerusalemme è l’edizione curata dai frati domenicani delle celebre Università Ècole Bilique, fondata nella Città Santa ed in merito riporta: “Il senso permissivo del verbo aramaico usato da Gesù, ‘lascia entrare’ e non ‘fare entrare’ non è reso dal greco e dalla vulgata”.
Per la migliore interpretazione di questo versetto si deve ricorrere necessariamente alla lingua parlata dal Cristo, l’aramaico. Siamo infatti a conoscenza che l’apostolo Matteo scrisse il Vangelo in questa lingua semitica, e proprio in aramaico con quell’espressione va tradotta con: “Non permettere che cadiamo quando siamo tentati”.
La preghiera chiederebbe dunque la forza necessaria per vincere la tentazione, piuttosto che di essere esentati dalla prova che, oltre tutto, giungerebbe da DIO stesso.
Tuttavia il latino in-ducas e il greco eis-enenkes riflettono anche un aspetto peculiare della teologia biblica, in cui è DIO stesso a “condurre” il credente “dentro nella prova” (come è narrato, per esempio, nel Libro di Giobbe), per renderlo più forte. Una prova quindi assolutamente sostenibile per il credente e non al di sopra delle proprie possibilità.
Il concetto di prova da superare per il credente è riportato brillantemente anche nella tradizione Musulmana. Il Corano in un magnifico passaggio di una delle Sure più importanti del Testo Sacro attesta:
DIO non impone a nessun’Anima un peso al di là di quello che può sopportare. Quello che ognuno [di buono] avrà guadagnato sarà a suo favore e ciò che [di male] avrà demeritato sarà a suo danno. “SIGNORE nostro, non ci punire per le nostre dimenticanze e i nostri errori. SIGNORE, non caricarci di un peso grave come quello che Tu imponesti a coloro che furono prima di noi. SIGNORE, non caricarci di ciò per cui non abbiamo la forza di sostenere.
(Corano 2, 286)
Anche la versione presente nel lezionario pubblicato nel dicembre 2007 dalla Conferenza Episcopale Italiana, ispirandosi a quello che poteva essere un originale aramaico, propone la traduzione “non abbandonarci alla tentazione”. Alcuni vangeli apocrifi hanno un’altra forma per la frase in questione, argomentando implicitamente che DIO non può tentare i suoi fedeli.
Relazioni con la preghiera Ebraica
La preghiera presenta alcune affinità con il Kaddish ebraico, dal quale si distingue principalmente per l’invocazione al “Padre nostro” e per l’uso confidenziale della seconda persona. Vi sono somiglianze tra il Padre nostro e il materiale biblico e post-biblico della preghiera ebraica, in particolare Kiddushin 81a (babilonese). “Sia santificato il Tuo Nome” si riflette nel Kaddish. “Non guidarci nel peccato” fa eco alle “benedizioni del mattino” della preghiera ebraica, mentre nella benedizione pronunciata da alcune comunità ebraiche dopo la sera, la Shema include una frase del tutto simile all’apertura della preghiera del SIGNORE: “Il nostro DIO in cielo, consacra il Tuo Nome e stabilisci il Tuo Regno per sempre e regna su di noi nei secoli dei secoli”.
Vi sono molti parallelismi anche nel primo Libro delle Cronache (1Cr 29, 10-18), dove Davide inizia a benedire DIO in questo modo:
10 Benedetto sei Tu, o ETERNO, DIO di Israele, nostro Padre, per tutta l’eternità.
11 Tua, o Eterno è la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, perché tutto ciò che è in cielo e sulla terra è Tuo. Tuo, o Eterno, è il regno, e Tu ti innalzi sovrano sopra ogni cosa.
(1Cr 29, 10-11)
Il Rabbino Aron Mendes Chumaceiro ha detto che quasi tutti gli elementi della preghiera hanno controparti nella Bibbia ebraica e nei Libri di Deuterocanonici: la prima parte in Isaia 63, 15-16 (“Guarda giù dal cielo e vedi, dalla tua Santa e bellissima abitazione … Per te sono il nostro Padre … “) ed Ezechiele 36, 23 (“Esprimerò la santità del mio Grande Nome … “) ed Ezechiele 38, 23 (“Mostrerò la mia grandezza e la mia santità e mi farò conoscere agli occhi di molte nazioni … “), la seconda parte in Obadia 1, 21 (“I salvatori saliranno sul monte Sion per governare il monte Esaù e il regno sarà per il SIGNORE”) e 1Samuele 3, 18 (“… È il SIGNORE. Lascia che faccia ciò che gli sembra buono”), la terza parte in Proverbi 30, 8 (“… nutrimi con il pane che è ame destinato”), la quarta parte in Siracide 28, 2 (“Perdona al prossimo il torto che ha fatto, e allora i tuoi peccati saranno perdonati quando preghi”). “Liberaci dal male” può essere paragonato al Salmo 119, 133 (“… non lasciare che l’iniquità mi domini”).
Anche Chumaceiro afferma che, poiché l’idea di DIO che guida un essere umano in tentazione contraddice la giustizia e l’amore di DIO, “non ci indurre in tentazione” non ha contropartita nella Bibbia ebraica (l’Antico Testamento cristiano), e quindi impossibile da attribuire alla dottrina del Maestro (Rabbì) Gesù.
La parola “πειρασμός”, che è tradotta “tentazione”, potrebbe anche essere tradotta come “prova” o “test”, rendendo così evidente l’atteggiamento nel profondo del cuore di qualcuno. Esempi ben noti nell’Antico Testamento sono la prova di DIO per Abramo (Genesi 22, 1), il Suo “muovere/indurre” (la parola ebraica significa principalmente “pungere/punzecchiare, come da erbacce, o spine”) re Davide a fare (censendo Israele) un atto più tardi riconosciuto come peccato (2 Samuele 24, 1-10, vedi anche 1 Cronache 21: 1-7), e gli esempi nel Libro di Giobbe.
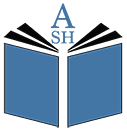
 English
English  Italiano
Italiano 








