Escatologico in Teologia è un qualcosa che si riferisce all’escatologia, ovvero relativo al destino ultimo dell’uomo, dell’umanità e dell’universo (dottrine escatologiche).
Questa dottrina riguarda quindi i destini ultimi dell’umanità e del singolo individuo. È una parte delle credenze coessenziale all’idea stessa della religione e questo spiega perché credenze escatologiche s’incontrino sia tra le popolazioni cosiddette primitive sia presso le religioni superiori.
1. Religioni di interesse etnologico
Concepita la natura come insieme organico unitario, l’escatologia si configura nelle religioni primitive quale rappresentazione di una realtà al di fuori del tempo, ricostituita in unità dopo le lotte ciclicamente causate dal male nel mondo della natura, causate e definitivamente superate per l’intervento, all’apice di una serie di cataclismi cosmici, di un Essere Divino. Spesso associata all’idea di una ricostituzione di un nuovo mondo, in cui siano banditi malattie, morte e dove la nuova terra non avrà animali feroci o uomini i malvagi.
Rappresentazioni escatologiche di un ritorno di un essere divino si trovano anche presso le popolazioni pigmee del Gabon, o le popolazioni tatare dell’Altai ed altre. Nel nuovo mondo la felicità sarà completa, non ci sarà più una “terra degli spiriti” (= morti) e la divinità vivrà come una madre con i suoi figli.
2. Religioni orientali
Presso l’induismo e il buddhismo l’escatologia si configura essenzialmente come reazione a una concezione negativa del mondo empirico. Presupposto comune alle due religioni è la teoria della successione ininterrotta di stati di vita, condizionati dalla condotta nelle fasi antecedenti. La visione dello stato ultimo, pertanto, non può essere che la liberazione dal contingente, mediante la pratica ascetica, l’acquisizione della vera scienza, sino al raggiungimento della beatitudine del nirvana, immoto e indistinto non-essere, termine ultimo di una visione escatologica in cui il rilievo è dato alla posizione individuale, su di un piano di sostanziale svalutazione della storia, intesa come sviluppo lineare.
3. Escatologia giudaica
Del tutto calata nella storia è l’escatologia ebraica, il più tipico esempio di concezione dei fini ultimi riguardante la posizione di un’intera collettività, quella appunto del popolo eletto di DIO. L’escatologia non è tanto la prospettazione della fine del mondo, quanto la rappresentazione di un trionfo anche politico della parte del popolo eletto mantenutasi fedele a DIO, che da castigatore si farà salvatore e regnerà in una nuova Gerusalemme su tutte le nazioni del Mondo.
Particolare importanza assume, in questo contesto politico-nazionalistico, la “visione” contenuta nel Libro di Daniele, in cui il trionfo finale di Israele, avviene a opera del «figlio dell’uomo». Fra il 1° sec. a.C. e il 1° d.C. acquista sempre maggior risalto questa figura di un messia redentore, inteso come un re guerriero. In alcuni settori del giudaismo, tuttavia, l’escatologia supera la pura prospettiva nazionalistica e attinge una dimensione universalistica concernente il problema del male in generale.
4. Cristianesimo
4.1 Parusia e messianismo
L’idea messianica fu ripresa e sviluppata in ambiente cristiano, per l’annuncio evangelico dell’imminente avvento del Regno di DIO. L’assunzione dell’elemento escatologico nei termini del messianismo contribuì a diffondere, specie nelle persecuzioni subite dai Cristiani nei primi secoli, l’aspettativa di una parusia, intesa come ritorno dello stesso Cristo quale restauratore di un regno messianico sulla terra. Il diffondersi del millenarismo è spiegato dalla necessità di dare una dimensione precisa al differimento della parusia, giustificato dalla possibilità offerta a tutti di salvarsi, stabilendo in mille anni la durata per il regno messianico intermedio. Questa dimensione escatologica, nutrita di elementi tratti dall’Apocalisse, ebbe nel 2° sec. numerosi seguaci (per es., Papia di Ierapoli, s. Giustino, s. Ireneo, Tertulliano ecc.). Già in s. Paolo, e più ancora in s. Giovanni, comunque, la spiritualizzazione dell’escatologismo si era precisata nel senso di un’escatologia di realizzazione, di contro a quella di attesa. In Oriente, nell’opera di Origene, l’escatologia si liberò di ogni elemento apocalittico giudaico per dar luogo a una concezione ciclica della storia dell’umanità e del mondo, che consentì il precisarsi, per la prima volta, di un’escatologia individuale, pur nell’ammissione del raggiungimento di una apocatastasi (un ritorno allo stato originario) collettiva per intervento del Redentore, con la soppressione del male.
4.2 S. Agostino
Una nuova prospettiva è data da s. Agostino con la dottrina delle due città, quella del mondo e quella di DIO, la quale vive nella realtà del mondo, ma non si identifica con una società temporale e costituisce lo storico realizzarsi del trionfo di Cristo nella Chiesa. Agostino descrive minutamente le caratteristiche e i segni premonitori della parusia, trasmettendo tutto un bagaglio escatologico alla meditazione del Medioevo, che accolse altresì elementi del messianismo giudaico, con la figura dell’imperatore degli ultimi tempi, e dell’Apocalisse, con le figure dei popoli di Gog e Magog.
4.3 Il dibattito contemporaneo
Circa il valore dell’escatologia nell’ambito dell’essenza stessa del cristianesimo, si è sviluppata nel 20° sec. una vivace polemica tra cattolici e protestanti. Per alcuni di questi (A. Schweitzer) l’escatologia è solo la dimensione esteriore del pensiero di Cristo, assunta come essenziale dalla primitiva tradizione cristiana per effetto dell’ambiente giudaico; per altri (K. Barth) l’escatologia ha ancora un’importanza nel cristianesimo, ma in senso intemporale, restando oggetto di un’attesa e di una speranza fondata sulla promessa di Cristo, sulla certezza dell’azione redentrice da lui operata; per altri ancora (R. Bultmann) l’escatologia è trasferita totalmente dall’avvenire al presente, alla quotidiana esistenza, realizzandosi attraverso l’azione della grazia, che rende presente in ognuno, al di fuori di una vera dimensione temporale, il fatto della venuta di Cristo nel mondo, verificatosi nel passato.
5. Islam
L’escatologia islamica è l’aspetto della teologia islamica che riguarda le idee della vita dopo la morte, le questioni dell’anima, e il “Giorno del giudizio”, conosciuto come Yawm al-Qiyāmah (arabo: يوم القيامة, “il Giorno della Resurrezione”) o Yawm ad-Dīn (يوم الدين, “il Giorno del giudizio”). Il Giorno del Giudizio è caratterizzato dall’annientamento di tutta la vita, che sarà poi seguito dalla risurrezione e dal giudizio di DIO. Più versetti del Corano citano il Giudizio Universale.
Il soggetto principale di Surat al-Qiyama è la resurrezione. La Grande Tribolazione è descritta nell’hadith e nei commenti dell’ulama, tra cui al-Ghazali, Ibn Kathir, Ibn Majah, Muhammad al-Bukhari e Ibn Khuzaymah. Il Giorno del Giudizio è anche conosciuto come il Giorno del Ricongiungimento, l’Ultimo Giorno e l’Ora (al-sā’ah).
A differenza del Corano, l’hadith contiene diversi eventi, che accadono prima del Giorno del Giudizio, che sono descritti come diversi segni minori e dodici segni maggiori. Durante questo periodo, la terribile corruzione e il caos domineranno la terra, causati dal Masih ad-Dajjal (l’Anticristo nell’Islam), poi apparirà Isa (Gesù) che con l’aiuto del Mahdi, sconfiggerà il Dajjal e stabirà un periodo di pace, liberando il mondo dalla crudeltà. A questi eventi seguirà un periodo di serenità, quando le persone vivranno secondo i valori etici e religiosi.
Come in altre religioni abramitiche, l’Islam insegna che ci sarà una resurrezione dei morti seguita da una tribolazione finale e da un’eterna divisione dei giusti e dei malvagi. La letteratura apocalittica islamica che descrive l’Armageddon è spesso conosciuta come fitna, Al-Malhama Al-Kubra (Il grande massacro) o ghaybah in Shī’a Islam. I giusti saranno ricompensati con i piaceri della Jannah (Paradiso), mentre gli ingiusti puniti nella Jahannam (Inferno).
Secondo un sondaggio del 2012 di Pew Research, il 50% o più dei musulmani in diversi Paesi a maggioranza musulmana (Turchia, Malesia, Afghanistan, Pakistan, Iraq, Tunisia, Libano, Marocco) si aspettano che il Mahdi ritorni durante il periodo che loro sono in vita.
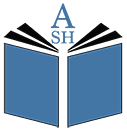
 English
English  Italiano
Italiano 








