L’Islam (in arabo: إسلام, Islām) è una religione Abramitica (monoteista) originaria della penisola araba nel VII secolo dell’era cristiana grazie alla rivelazione di DIO per mezzo del Profeta Maometto (in arabo محمد, Muḥammad), considerato dai musulmani l’ultimo profeta portatore di legge (Khātam al-Nabiyyīn) inviato da DIO (in arabo الله, ALLAH) al mondo per ribadire definitivamente la Rivelazione, annunciata per la prima volta ad Adamo (آدم, Ādam), il primo uomo e il primo profeta della Bibbia.
Con circa 1,6 miliardi di fedeli, ossia il 23% della popolazione mondiale, l’Islam è la seconda religione del mondo per consistenza numerica e vanta un tasso di crescita particolarmente significativo. Il 13% dei musulmani vive in Indonesia, che è anche il paese musulmano più popoloso, il 25% nell’Asia meridionale, il 20% in Vicino, Maghrebe Medio Oriente e il 15% nell’Africa subsahariana. Minoranze considerevoli si trovano anche in Europa, Cina, Russia e Americhe.

Etimologia e significato
Islam (pronunciato [isˈlaːm] in arabo) è un sostantivo verbale traducibile con «sottomissione, consegna totale [di sé a DIO]» che deriva dalla radice aslama, congiunzione causale di salima («essere o porsi in uno stato di sicurezza»), ed è collegato a salām («pace»).
Nel linguaggio religioso, il concetto è traducibile con la parafrasi: «entrare in uno stato di pace e sicurezza con DIO attraverso la sottomissione e la resa a Lui». Nel Corano talvolta assume la caratteristica di una qualità interiore del fedele: «ALLAH apre il cuore all’Islàm a coloro che vuole guidare»; altri versi collegano Islām e Dīn, approssimativamente traducibile «religione»: «Oggi ho reso perfetta la vostra religione [dīn], ho completato per voi la Mia grazia e Mi è piaciuto darvi per religione l’Islàm». Altri ancora descrivono l’Islam come «l’atto di ritorno al vero DIO, il DIO Unico di Abramo», piuttosto che un’affermazione verbale di fede. La parola Islam perciò non è legata a una personalità o a un gruppo etnico, bensì all’idea centrale del suo credo religioso.
Nell’ aḥādīth (gli scritti risalenti alla tradizione orale sulla vita del Profeta Muhammad) di Gabriele (ʾaḥādīth Jibrīl) l’Islàm è presentato come parte di una triade composta da imān («fede») e iḥsān («eccellenza»), dove la definizione teologica dell’Islam sarebbe il Tawḥīd (quella storica, l’affermazione di fede nella missione profetica di Maometto, quella dottrinale nel rispetto dei Cinque Pilastri).
 I Pilastri dell’Islam
I Pilastri dell’Islam
Gli arkān al-Islām (“Pilastri dell’Islam”) sono i cinque doveri assolutamente cogenti per ogni musulmano osservante (pubere e sano di corpo e di mente) per potersi definire a ragione tale. Essi sono:
- la shahāda, o “testimonianza” di fede:
“Ašhadu an lā ilāha illā ALLAH – wa ašhadu anna Muḥammadan Rasūl ALLAH”
“Testimonio che non c’è divinità se non DIO (ALLAH) e testimonio che Muḥammad è il Suo Messaggero“.
Per essere valida, la shahāda deve essere recitata con piena comprensione del suo significato e in totale sincerità di intenti. Essa è sufficiente, da sola, a sancire l’adesione all’Islam di chi la pronuncia.
- la ṣalāt (in arabo صلاة), preghiera canonica da effettuare 5 volte al giorno, in precisi momenti (awqāt) che sono scanditi dal richiamo (in arabo أَذَان, adhān: ) dei muezzin (in arabo مؤذن, muʾadhdhin), che operano nelle moschee (oggi spesso sostituiti da registrazioni diffuse con altoparlanti);
- la zakāt (in arabo زكاة), offerta in denaro – obbligatorio per ogni musulmano che possa permetterselo – che rende lecita la propria ricchezza; da devolvere nei confronti di poveri e bisognosi. Nella quasi totale assenza ormai dello Stato tradizionale percettore – che era dotato di appositi funzionari (ʿummāl, pl. di ʿāmil) con ampi poteri cogenti – la zakāt è oggi prevalentemente autogestita dal pio musulmano, anche se esistono organizzazioni che forniscono aiuto ai fedeli per raccogliere fondi da destinare a opere di carità, per la cui realizzazione la giurisprudenza islamica ha previsto da sempre l’utilizzo delle somme raccolte tramite questa pratica canonica. La somma da versare, a cadenza annuale, viene calcolata sulla base di un imponibile del 2.5% sul capitale finanziario del fedele, e vale anche per le aziende. L’OCHA ha calcolato che i volumi annuali di tali versamenti sono, come minimo, superiori anche di quindici volte ai valori totali delle donazioni a livello mondiale;
- Ṣawm ramaḍān (in arabo صوم رمضان), ovvero digiuno – dal tramonto al sorgere del sole – durante il mese lunare di Ramadan per chi sia in grado di sostenerlo senza concrete conseguenze negative per la propria salute;
- Ḥajj (in arabo حج), pellegrinaggio canonico a Mecca e dintorni almeno una volta nella vita, nel mese lunare di Dhū l-ḥijja, per chi sia in grado di sostenerlo fisicamente ed economicamente.
In ambienti come quelli sciita, kharigita e sunnita-hanbalita si aggiunge un sesto pilastro: il jihād (in arabo ﺟﻬﺎﺩ), ma se nella sua accezione di “jihād maggiore” (akbar, dice la giurisprudenza), teso cioè a combattere gli aspetti più deteriori dell’animo umano, esso è accettato da ogni scuola di pensiero sunnita come un potenziale sesto pilastro, la sua accezione di “impegno sacro armato” è talmente densa di condizioni e limitazioni da non consentire che il “jihād minore” (jihād aṣghar) sia accettato sic et simpliciter dal madhhab hanafita, malikita e sciafeita come sesto degli arkān al-Islām.
Ecumenismo islamico
L’Islam è considerato dai suoi fedeli come l’insieme delle rivelazioni elargite da DIO all’umanità fin dall’epoca del suo primo profeta, Adamo. I musulmani non considerano l’Islam come l’ultima Rivelazione in ordine di tempo rispetto alle altre due grandi fedi Abramitiche (Ebraismo e Cristianesimo), ma come l’ennesima conferma, la riproposizione della Volontà Divina all’umanità, resa necessaria a fronte delle continue manomissioni (taḥrīf) dei Testi Sacri o delle dottrine causate dall’effetto del fluire del tempo e delle azioni (talora maliziose) degli uomini. Torah (Tōrāh), Salmi, Avesta e Vangelo (Injīl), cui si aggiungeranno in seguito anche i Veda dell’Induismo, sono perciò considerati Testi che, in origine, non contenevano rivelazioni diverse da quella Coranica, ovvero la sottomissione al DIO Unico.
Muhammad è definito dall’Islam quindi “il sigillo dei profeti” (khaṭam al-nabiyyīn) e questo è un principio fondamentale per la fede islamica. Gli ortodossi, ritengono che con la sua morte sia terminato per sempre il ciclo profetico musulmano (tanto che viene accusato di massima empietà, kufra, chiunque lo dichiari riaperto). Nell’Islam vengono pertanto riconosciuti tutti gli insegnamenti Biblici dell’Antico e del Nuovo Testamento, della cui origine celeste non si discute, riconoscendo per logica conseguenza il carisma dei profeti vetero-testamentari (da Adamo a Noè, da Abramo a Mosè), come anche quello di Gesù. Secondo i musulmani, il Corano è però l’unica fonte non modificata che attesti la volontà divina, destinata a perdurare inalterata fino al Giorno del giudizio.
Nel Corano, la Sura CXII – al-Ikhlāṣ o “del culto sincero” – fornisce la definizione che DIO dà di sé:
-
Di’: «Egli, DIO, è Uno, DIO, l’Eterno. Non generò né fu generato e nessuno Gli è pari».
Questa sura è considerata la perfetta sintesi dell’Unità di DIO, o Tawḥīd, che a sua volta incorpora le caratteristiche dell’Altissimo: egli è Unico (wāḥid) e Uno (aḥad).
Avendo tali caratteristiche, l’Islam rigetta apertamente la Trinità e la visione divina di Gesù, ma ne attende il ritorno alla fine dei tempi. DIO, entità completamente trascendente, esiste senza avere luogo poiché è Egli stesso il luogo della Sua esistenza; insostanziale, incorporeo, non definibile e non raffigurabile. Tutto l’esistente, di cui è il Creatore ex-nihilo, non è altro che un Suo segno, una Sua manifestazione e un Suo riflesso attraverso cui Egli si rende conoscibile:
-
“Io ero un tesoro nascosto e volevo essere conosciuto. Ho creato le creature per essere conosciuto.”
Ed è dunque abbandonandosi con fiducia a DIO che il musulmano guadagna la guida del SIGNORE:
- “Io sono secondo l’idea che il Mio servo ha di Me, e Io sono con lui quando Mi menziona; e se Mi menziona in cuor suo, lo menziono in cuor Mio. E se Mi menziona in pubblico, lo menziono in un pubblico migliore di quello; e se si avvicina a Me di un palmo, Mi avvicino a lui di un cubito; e se si avvicina a Me di un cubito, Mi avvicino a lui di un braccio; e se viene da Me camminando, vado da lui correndo.”.
Vita, scienza, potenza, volontà, udito, vista e parola sono attributi che pur appartenendogli totalmente, non ne alterano l’Unità. Il tempo non è una creazione ontologicamente distinta da Lui. Sovraintende la vita degli uomini senza che questi possano vederlo, poiché “non l’afferrano gli sguardi ed Egli tutti gli sguardi afferra“, ma è pronto ad aiutarli qualora ne avessero bisogno ed è all’uomo “più vicino della vena giugulare“, rendendo superflua ogni intermediazione sacerdotale. Attraverso i suoi 99 nomi è possibile invocarlo, ma data la sua natura trascendente e oscura all’uomo “non v’ha simile a Lui cosa alcuna“, l’Islam rifiuta l’idea che DIO assomigli fisicamente alla sua creatura umana o che vi sia il benché minimo spazio per una concezione antropomorfica di ALLAH.
I 99 nomi di DIO mirano a qualificarne l’Essenza (kawn), esplicitata attraverso tale elenco di attributi: egli sarebbe dunque tra le altre cose, l’Eterno (Ṣāmad), la Verità (al-Ḥaqq), l’Esistente di per Sé (al-Ḥayy al-Qayyūm), il Sublime (al-ʿAẓīm), il Potente (Qadīr,), Il Sapiente (al-Ḥakīm), ma anche al-Badīʾ, “Il Creatore di ogni cosa”. La sua Onniscienza è chiaramente enunciata:
-
“È il Primo e l’Ultimo, l’Evidente e il Nascosto, e conosce tutto.”
Luoghi di culto
Luogo deputato (ma non indispensabile) alla Ṣalāt è la moschea (in arabo masjid, al plurale masājid). Non necessariamente delegata a fini liturgici, essa funge anche da luogo d’incontro, di studio e persino di riposo. Al suo interno si usano compiere le cinque preghiere giornaliere obbligatorie, la rottura del digiuno del ramaḍān, la raccolta e ridistribuzione dei fondi della zakāt.
Dal punto di vista storico, oggi si ritrovano ancora nelle moschee di tutto il mondo elementi introdotti dalle prime moschee di Mecca e Medina: è il caso del miḥrāb, del minbar, e di un largo cortile esterno, il sahn (che poi si sarebbe diffuso anche alle case private), in cui spesso si trovano fontane, o ḥawḍ, indispensabili al compimento delle abluzioni necessarie per il conseguimento della purità rituale.
La moschea rappresenta di gran lunga l’espressione preminente dell’architettura islamica, a sua volta influenzata dalle normative che regolano l’arte sacra in generale: non vi sono quindi ospitate, in linea generale, rappresentazioni umane o animali. La geometria assume dunque un ruolo di collegamento fra realtà umana e trascendenza divina, data la natura infinita e onnipresente, Una e Unica di ALLAH. Per proiettare questi principi, appartenenti alla dottrina teologica islamica o Tawḥīd, nella moschea si utilizzano forme e decorazioni tese a trasmettere al fedele la consapevolezza riguardante la stretta correlazione esistente fra il mondo esterno delle forme e quello interiore delle realtà divine, essendo entrambe, per la concezione islamica, appartenenti ad ALLAH, considerato sia al-Ẓāhir, “Manifesto”, sia al-Bātin, “occulto”.
A causa di questo stretto rapporto fra teologia e geometria gli architetti musulmani progredirono notevolmente nelle scienze matematiche, scoprendo, per esempio, formule che in Occidente sarebbero diventate note solo nel XX secolo. Principali espressioni di questa ricerca sono il girih e l’arabesco.
La contrarietà a rappresentare immagini umane è dettata dall’assenza nel pensiero islamico sunnita del concetto di santità e dalla possibilità che un qualsiasi essere umano – con l’eccezione di Maometto – possa intercedere per l’essere umano presso DIO, oltre che dalla precisa determinazione d’impedire qualsiasi degenerazione idolatrica del culto.
I Profeti
I musulmani dichiarano che la loro religione si riallaccia direttamente alle tradizioni religiose che sarebbero state predicate dal patriarca biblico Abramo (Religioni Abramitiche), considerato da Maometto come il suo più autorevole predecessore. La ragione è che l’Islam provenga dai discendenti di Ismaele (primogenito del patriarca Abramo con la schiava Agar), mentre gli ebrei provengono dalla stirpe di Isacco (figlio del patriarca Abramo con la moglie Sara) e i cristiani sarebbero gemmati dall’ebraismo dopo la predicazione di Gesù e successivamente, con Paolo di Tarso iniziò ad accogliere anche i non-ebrei. Ismaele e Isacco erano quindi figli di Abramo, sebbene il primo fosse di madre araba e il secondo israelita (fatti tuttavia senza particolare significato in una cultura patrilineare e patriarcale). È per questo che l’Islam viene classificato come religione Abramitica, al pari dell’Ebraismo e del Cristianesimo.
Il primo profeta per l’Islam equivale al primo patriarca Adamo e, dopo di lui, Nūḥ (Noè) e gli altri fino a Gesù e Muhammad. Sono annoverati fra i tanti profeti, dopo Ibrāhīm (Abramo), suo cugino Lūt (Lot), i suoi figli Isḥāq (Isacco) e Ismāʿīl (Ismaele), Yaʿqūb (Giacobbe), Yūsuf (Giuseppe), Mūsā (Mosè), Dāwūd (Davide), Sulaymān (Salomone), Yaḥyā (Giovanni Battista) e, prima di Muḥammad, ʿĪsā ibn Maryam (cioè Gesù il Nazareno, figlio di Maryam, ossia Maria), Maria è considerata anche nel Corano come esempio sublime di devozione femminile a DIO (ALLAH).
Altri profeti citati dal Corano sono: Idrīs (probabilmente Enoch e Esdra), Ṣāliḥ (probabilmente secondo il nome Biblico Sela), Hud (secondo alcuni Eber), Shuʿayb (proposto Ietro, accomunati dal fatto di essere entrambi Madianiti), Dhū l-Kifl (proposti Giobbe o Ezechiele), Dhū l-Qidr o Dhū l-Qadir (il suo racconto è ispirato a quello del babilonese Ūmnapīštīm, non c’è equivalente giudeo-cristiano) e Dhū l-Qarnayn (Il Bicorne), identificato principalmente con Alessandro Magno o Ciro il Grande).
Continua >>> Pagina 2
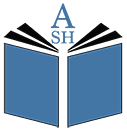
 English
English  Italiano
Italiano 










